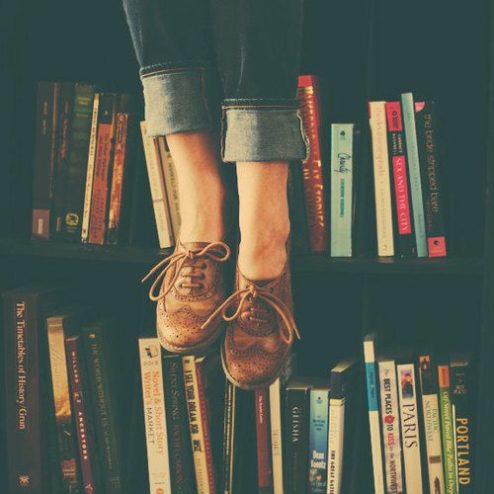Bordello Story, se fosse possibile fare un film dal mio 2019
Qualche settimana fa ho rivisto “La meglio gioventù”, sostanzialmente perché avevo bisogno di ricondurre i miei drammi personali alla storia italiana mirabilmente interpretata da Luigi Lo Cascio.

La maggior parte dei miei contatti Facebook piangeva su Marriage Story, mi arrivavano messaggi pvt in cui mi si diceva che Scarlett Johansson mi somigliava molto in quella pellicola o il contario, io somigliavo molto a Scarlett Johansson in quella pellicola, probabilmente perché Scarlett Johansson ha un taglio di capelli orribile, indossa vestiti sformati color beige, ha idee confuse su se stessa e piange per tre quarti del film. A questo proposito: dire a qualcuno che assomiglia a Scarlett Johansson durante una crisi non è un gran complimento. Inoltre, ho visto il film e posso affermare che:
a) i due sono dei principianti a livello di litigi, la loro scena madre è il mio pezzo di apertura;

b)avessi i soldi per prendere tutti gli aerei, pagare tutti gli avvocati e cambiare tutte le case che cambiano i protagonisti, ma quale crisi, seriamente: invece dei documenti per il divorzio, io avevo già messo in mano a mio marito il numero di una baby-sitter e poi una bella letterina che annunciava la mia partenza per due mesi alle Maldive pagati da lui. La lettera fa così, leggetela con la voce impostata ma incrinata dal pianto:
Caro amore mio, ti amo dalla prima volta che ti ho visto, probabilmente ti amerò per sempre. Ma. Ma hai fatto la palla. Le critiche sono l’unica cosa che ti viene spontanea e, per il resto, mi dispiace dirtelo, ma sei emotivamente stitico, infatti il film si chiude solo quando tu piangi mentre io lo faccio dall’inizio del film, cosa che trovo assai sessista: me l’avessero detto prima, t’avrei dato un bel calcio negli stinchi e via. Sai com’era bella una scena di me che ti prendo a calci in culo per tutto l’appartamento dicendo che è una mia idea per la tua performance teatrale? Comunque, mentre tu vedi un terapeuta, io ho urgente bisogno di bere latte di cocco da una noce di cocco, farmi di nuovo bionda, comprarmi anche un paio di tacchi che non hai idea e pareggiare il conto delle corna. Poi vediamo tutto il resto, intanto salutami Kramer contro Kramer nella versione for dummies, ci vediamo poi.
Dunque ho visto “La meglio gioventù” e passato quattro ore circa – era la versione ridotta su Amazon Prime – a piangere moltissimo. Piangere moltissimo per me significa lacrimare silenziosamente tirando su con il naso e cercando di non morire soffocata dal mio stesso muco (sì, fa un po’ schifo, ma non sono Chiara Ferragni, so di non “piangere in maniera carina” cit.)(Ho visto anche Unposted di Chiara Ferragni, sì, e lo trovo meglio di Marriage Story come trama e colonna sonora). Ho terminato la visione della serie capolavoro di Marco Tullio Giordana, la nostra versione dell’Heimat tedesco (tu che mi leggi e sai cos’è l’Heimat, esisti davvero? Inizio a dubitarne) e ho iniziato a ragionare sulla mia vita.
Sono terribilmente sensibile ai decenni. Ricordo ancora con terrore lo spot della Rai nel 1989, in cui si invitavano i gentili telespettatori a cambiare decennio insieme. Purtroppo non ho più sei anni, quindi non posso nascondermi sotto le coperte nella camera da letto di mia zia. In più c’è il fatto che l’anno di grazia 2019 ha fatto talmente schifo che certe volte mi sono fatta non schifo ma pietà da sola. Posso ricondurre il tutto a dinamiche storico-sociali-familiari, ma non ho le mie classiche, bellissime, serenissime, superzen illuminazioni serafiche sulla vita, quanto la consapevolezza fisica che la vita mi ha pigliato a calci in culo e se ho fatto qualche passo avanti è stato per l’onda d’urto. Perché non esiste, dunque, una trasposizione filmica? Scarlett Johansson in fondo è già lì pronta, basta farle crescere i capelli o metterle le extension, e stiamo apposto con la protagonista, i costumi e la congiuntivite.
BORDELLO STORY
Regia, soggetto e sceneggiatura di Raffaella R. Ferré
Il film comincia a gennaio 2019 con Scarlett e il marito, interpretato da Mark Ruffalo sullo stile Avengers Endgame, che cambiano casa. Sì, so che Mark Ruffalo in Avengers Endgame impersona l’Incredibile Hulk. Comunque, la casa è piena di luce, viene scelta soprattutto per questo: il modo in cui il sole si riflette sul bel pavimento in legno scuro assai rovinato, l’ombra rosa che ha la meglio nel pomeriggio; la casa è anche vuota e – finalmente – ha delle porte – ben 5 in luogo delle 2 presenti nella vecchia! – e forse per questo sembra immensa anche se non lo è. Arredarla prende circa 80 minuti di un film che ne dura 120, durante i quali i protagonisti non fanno altro che tentare di non uccidere la tizia di Ikea Afragola che gli fa da consulente. Poi si rassegnano, chiedono la consulenza online, Scarlett e il tizio in vivavoce dall’accento emiliano si intendono subito e, colpo di scena, le dà la notizia dell’esistenza di un mobiletto dalle magiche misure 30 di larghezza e 60 di profondità con cui completare una bellissima cucina mignon in materiale riciclato e non inquinanante ben prima che nascesse la moda dei Friday for Future. Foreshadowing su Scarlett che disegna con il CAD la cucina, tentando diversi stili: quello classico con anta Bobdyn in colore azzurro polvere che però fa troppo casa di Barbie e quindi viene scartato; quello moderno, anta Kungsbacka bianco non lucido per i pensili, nero non lucido per la base con carello in legno così può giocare a vincere Masterchef ogni volta che cucina. A sostegno della cosa, Scarlett indossa anche il grembiule del Pressure Test.

La cosa si fa, però, pericolosa quando la donna inizia a sviluppare una singolare affezione per i nomi di ogni singolo componente del mobilio svedese, dalle tende a pacchetto Ringblomma a tutti gli Ursta che ammorbidiscono la chiusura dei cassetti, fino a maturare una certa affezione per la collezione Hemnes. Invece di tentare la scalata al colosso dell’arredamento scandinavo, Scarlett trova edificante punzecchiare suo marito sui quadri da appendere, che letto prendere, quale divano. L’unica cosa su cui concordano sono le librerie a tutt’altezza. Lei vorrebbe ridipingere una parete, chiedere ad un’amica vignettista bravissima di farci su una scritta – la più gettonata è “La vita è un varieté” e se tu che mi leggi conosci il verso successivo ti stimo, ma qui sono certa che esisti e la cosa non mi stupisce -; lui è invece nella fase minimalismo giapponese dopo Hiroshima, ergo le pareti restano spoglie se non per due lavagnette che vengono aggiornate settimanalmente da lei con i gessetti colorati: recano la lista della spesa, disegnini e frasette motivazionali. La cosa ha il suo culmine nel mese di aprile/maggio in cui avviene effettivamente il trasloco, condito dalle lacrime di lei per la casa che lascia (qui lo spin-off) e dalle bestemmie di lui per la quantità di roba accumulata in 7 anni e da impacchettare e trasportare con l’aiuto della ditta Papillon (riferimenti cinematografici a go-go) composta da un gentilissimo uomo di cui non ricordo il nome, forse Francesco, e il suo treruote. L’arredamento viene composto da una squadra di slavi capitanata da tale Adrian che, per mezza giornata, qualsiasi dubbio abbia, chiama “Signora” alla stessa identica maniera in cui chiamerebbe Gesù Cristo chiedendogli il perché della fame nel mondo. Scarlett non se la prende per la cosa, anzi, si appassiona al lavoro dei baldi giovani dell’est e alla fine Adrian la invita a fumare una sigaretta sul balcone. Il momento illuminante, è, infine, quando Scarlett va a comprare il bidet nuovo, ma giacché non dispone di auto, si carica nella macchina del negoziante insieme al suo nuovo amico.

Il film potrebbe finire qui, con la prima notte in cui la coppia dorme nella casa nuova: è quella in cui trasmettono l’ultima puntata di Gomorra – La serie. Effettivamente i due dormono nella casa nuova per guardare l’ultima puntata di Gomorra – La serie. Nella prima casa, si erano decisi a trasferirsi per guardare la finale di Sanremo, quindi forse c’è un miglioramento o una morale, del tipo: vedi, le cose cambiano, cambia la scenografia dei palazzi fuori dalla finestra, ma noi no e teniamo botta ormai dal 2005 nonostante i palinsesti televisivi. Musica, precisamente Domenica di Coez – canzone che i due ascoltano molto – , e titoli di coda su lui che ordina la cena su Just Eat perché non hanno ancora consegnato il frigorifero.
THE END
Purtroppo però il 2019 non è un film con una sua durata e, potenza delle storie, un arco narrativo, ergo, la cosa continua, il racconto no. Ci sono poche cose con cui sono abbastanza in pace da poterle raccontare o verso cui ho maturato il distacco necessario per farne una storia e anche una risata. Scarlett dovrebbe vedersela con lo stress accumulato, i conti, i bordelli delle ultime cose, gli scatoloni da sistemare, tutto adeguatamente giustapposto al lavoro e a una situazione meteo inclemente fino al 7 di giugno. L’arrivo dell’estate non farebbe che complicare le cose, Scarlett si sentirebbe addosso pochissime energie e tantissimo da fare, senza sosta, mai. Alcune sono cose in copione e lì, come dire, anche se prende più paccheri di Rocky in Rocky 1-2-3 e 4 (Rocky si può vedere solo fino al numero 4), alla fine se la cava, deve cavarsela, anche quando i paccheri arrivano da persone da cui proprio non se lo aspettava. Altre cose invece no, altre cose vengono fuori dal nulla e cambiano improvvisamente il genere della pellicola, incendiandola nel caldo di agosto al Cardarelli, pure le cose da fare bruciano, insieme ai riferimenti cinematografici. Poi, sarà stato il cambio di temperatura, a un certo punto la paura si solidifica, Scarlett la vede, la sente, le si innesta sulla schiena in una forte discopatia che, le viene detto, potrebbe portarla alla zoppìa, alla paralisi, bisogna operare, forse, mo vediamo. Lei le tocca con mano – la schiena, le gambe e la paura – , e chiede finalmente la famosa mano che tutti si pregiano di volerle dare da anni. La mano che stringe alla fine è quella di un medico che le dà prima una cura da cavallo e le fa poi un’iniezione spinale di cortisone che non risolve il problema ma la rimette in piedi; la mano che tiene, alla fine, è la sua, per farsi i complimenti, più che altro, sulle saggissime decisioni che è capace di prendere (è ironico).
Nel 2019, oltre a quanto detto fin qui riducendolo ad una fiction, ho:
1) sfanculato una persona che mi ha rovinato le uniche due serate buone in 365 perché non l’avevo informata in diretta dell’aperitivo riuscito chissà come con un’altra persona e di cui era venuta a sapere perché aveva un profilo fake su Instagram (questo, portato nella versione filmica sarebbe un thriller meraviglioso);
2) lavorato senza sosta, mi pare bene, credo sia l’unica cosa che m’è riuscita;
3) dormito davvero credo 3 notti, me le ricordo perché mi svegliavo contenta la mattina, stupita di quanto mi sentissi sonnacchiosa e riposata;
4) pianto assai, sicuro più di Scarlett Johansson;
5) cucinato un botto, come se dovessi recuperare le settimane in cui, causa assenza suppellettili, non l’ho fatto.
6) inviato email e messaggi a tutti quelli che mi avevano detto di farlo, che c’erano sempre, avrebbero fatto qualsiasi cosa in caso di mia necessità, no matter what e quanto tempo è passato;
7) ritrovato il mio compagno fidato panico un pomeriggio su via Luca Giordano in cui non mi ricordavo più dov’ero e cosa stavo facendo;
8) apprezzato moltissimo chi, nonostante tutto, è stato capace di farmi ridere e sorridere, di sorprendermi, di preoccuparsi genuinamente per me (e cioè senza chiedere qualcosa subito dopo);
9) apprezzato ancora di più chi mi ha dato il braccio o mi ha raggiunto con i suoi piedi quando i miei non erano capaci.
10) Pensato e creduto fortissimo che voglio restare, anzi, tornare ad essere, una che parla in faccia, che dice le cose, che ha dolcezze e incazzature, invece di starmene muta e zitta da un canto.
Arrivo a questa fine anno cercando di riportare tutto in scala, dirmi che è solo un momento e non una vita intera, anche se, complice la fine del decennio, mi pare proprio così. La verità è che nel 2018 mi ero sentita finalmente responsabile di me stessa, mi ero detta che a nessuno tocca il compito di prendersi cura di te se tu per prima non lo fai, e mi ero rassegnata a prendermi la mia quota parte di merda, colpa e solitudine per come erano andate le cose nel 2017, nel 2016, nel 2015 e anche in parte del 2014, anno in cui la morte di mio padre dopo crudele malattia m’aveva portato a pensare che non potesse più succedermi niente di male, visto che il male era già successo e stava tutto da qualche parte nel mio cuore, come un cane nero, a mangiarselo. Invece, in questa prospettiva malamente dimenticata, il 2019 ha fatto da Armageddon: ho perso un’altra persona a me carissima, il cane è diventato lupo famelico e per il 2020 il mio unico proposito sarebbe dormire per un paio di mesi con la tv che manda a palla Ocean’s Eleven, film di cui sono assai grata perché DIO SANTO, è puro intrattenimento e non piange nessuno, grazie Steven Soderbergh, ti farò una statua.
La verità è che ho una paura fottutissima di qualunque cosa mi aspetta e non lo dico per:
a) farmi consolare;
b) ricevere un qualche messaggio motivazionale;
Lo dico perché è vero. E dire la verità, su me stessa, sulle cose e le situazioni che vivo, l’ho imparato nel 2019, è l’unica cosa che mi resta, forse perché non sopporto più le stronzate. Nel corso di questi ultimi 10 anni ho viaggiato molto per mezza Europa con una puntatina nel sud delle Americhe e anche da lì, che fossi su un battello nel Mar Baltico o nel cortile di un albergo di l’Havana, ho trovato il modo di fare una telefonata, inviare un messaggio a chi era dall’altra parte del mondo tenendo conto del fuso orario e non per fargli la palla, ma per fargli sentire il vento o la parlata spagnola. Nessuno ha ricambiato il favore, neppure quando il favore gli è stato chiesto. Vorrei che questo non meritasse un menzione, ma la merita: arrivo al 2020 con la consapevolezza che ho dato molto molto spazio e molto molto tempo e attenzione e cura a persone che erano, per me, la priorità, mentre io restavo e resto un’opzione. Non fa niente, però questo mi ha cambiato molto, e io avrei preferito restare com’ero.
Di questi tempi, dieci anni fa, avevo 26 anni, m’ero appena laureata, lavoravo in una tivù locale, portavo scaldamuscoli sopra gli stivali e gambe nude anche sul motorino. Credevo molto all’amicizia, all’amore, ai sogni e ai concetti astratti in generale. Credevo, ad esempio, che in carcere dovesse esserci un ufficio relazioni con il pubblico. Fa ridere? Rise molto la persona a cui lo dissi, stupendomi moltissimo. Ero così:
Ora sono così.

Non so quanto e se sono cambiata fisicamente, magari non più di tanto. Il conto degli anni che ho è semplice, anche se me ne sento 100 di più. Odio dovermi mettere le scarpe perché la schiena mi fa assai male, ma quando le metto e decido di essere più forte del dolore, sono capace di fare chilometri prima di fermarmi. Resto una che va veloce, ma se ho maturato sarcasmo e cinismo, diplomazia all’occorrenza e capacità di parlare come se volessi prendere a calci qualcuno quando serve, l’ho fatto solo perché costretta da altri e dalle circostanze. In questi anni ho sempre sperato che, davanti al mio cuore esposto e squadernato, ci fosse qualcuno capace di mostrarmi il suo: a volte è successo, altre no. Io ho imparato a vivere e andare avanti in entrambi i casi, sempre buttando il cuore oltre l’ostacolo come se non mi servisse più. Stavolta sono rimasti solo loro, una serie infinita di buche e transenne e salti da fare: il mio cuore, chissà dove l’ho lanciato, sicuro avanti. Mi tocca raggiungerlo, mi sa, riprendermelo, ficcarmelo tra le costole e non lasciarlo più andare. E niente: ci vediamo lì, tu che mi leggi: ci conto.