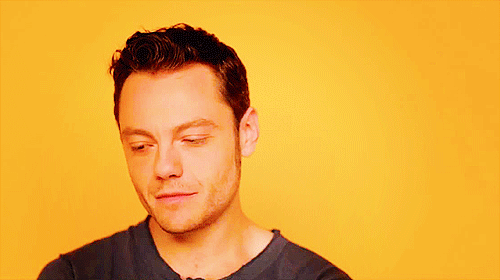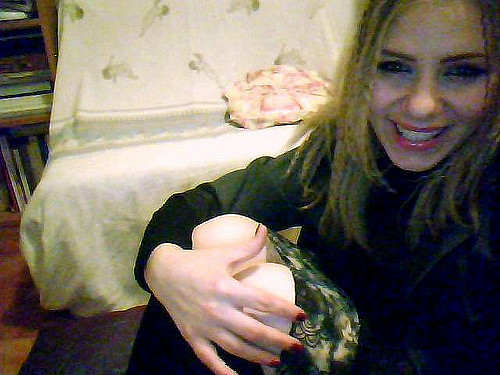A Tiziano (Ferro) per il suo compleanno
Questa mia è una dichiarazione d’amore e di intenti, ragionati quanto basta per essere una volontà: quella di fare un minimo di giustizia. Su Tiziano Ferro. Non che abbia bisogno delle mie parole a supporto ma mi farebbe piacere se questo giovane uomo di trentasette anni oggi, trovandosi un domani ad affrontare uno dei dilemmi che ha cantato – uno qualunque da “e non vuoi nessun errore però vuoi vivere” a “stavo attento a non amare prima di incontrarti” passando per “ricorderò e comunque, anche se non vorrai” – sapesse quanto sono importanti per altri, me compresa.
Dunque, cominciamo.
Sarei io, qui, la sottoscritta, una donna istruita che ha passato fasi adolescenziali: so chi era Soren Kierkegaard, ho un libro di Almudena Grandes accanto e i piatti di ieri sera ancora da fare. Ah, ho anche più di venticinque anni che mi sembra il limite massimo consentito dalla morale pubblica per farsi un piercing o un taglio di capelli radicale color blu cobalto. Cosa che farei, per l’appunto, se non avessi raggiunto i limiti di tempo per determinate capate a muro. Il fatto è che in tutte queste facezie sta la possibilità di salvarsi la vita, o un pomeriggio o un mese intero. Un anno anche, per dire.
Sono piccolezze trascurabili di fronte agli ideali sociali e politici, stramazzano di fronte alla collettività, davanti ad un titolo di giornale impallidiscono. Sono angoli, e chi ne tiene conto quando la strada da fare è così tanta e l’unico onore sembra ormai quello di riuscire a percorrerla senza che nulla ci turbi? Io, in pratica. E Tiziano.
Non so se avete mai osservato la gente in attesa da un parrucchiere, quando hanno già le idee chiare chiarissime e sfogliano un giornale nell’attesa di confessarle ad una specie di sacerdote della messa in piega. Non so se avete mai dato un occhio a quelli che arrivano in anticipo alla lezione di Pilates e stanno lì alla porta come fan roventi in attesa di un concerto. Non so se avete mai guardato in faccia uno che canticchia Tiziano Ferro e il suo “nanana-na-na-na“. Io sì (di nuovo), anche perché sono una di loro.
Comunque la cosa che si vede subito, che ti permette di non sentirti a disagio e di non vergognarti a starci in mezzo, è che reclamano un diritto non sancito da nessuna legge, perché non c’è nessunissima persona che ti dica che fai bene a incazzarti, crollare, piangere e poi esser capace di tirarti su con poco, che sia una canzone o una messa in piega o un’ora di dondolamenti su un materassino di spugna.
Ad ammettere queste cose potreste passare per mainstream,vi avverto. Se non ci tirate accanto un eco-bio, un coordinamento in cui siete persone attive o una bella citazione da De Gregori non potete nemmeno passare per radical-chic. Se non avete scritto un libro con una grande casa editrice il vostro trend sarà quello di uno/a sciocchino/a. E non vi dico cosa succede se vi scoprono a guardare le esterne di “Uomini e Donne” alla ricerca degli script comuni alle coppie (senza ricordare a chi vi ha beccato che su tale cosa ci hanno fatto un convegno nel ’78, certo non riguardava propriamente Maria De Filippi e il suo lavoro di mediatrice culturale, ma cazzo, la Cognitive Scienze Society riunita a La Jolla aveva chiamato i mastri dell’Intelligenza Artificiale, psicologi, linguisti, neuroscienziati e filosofi e stavano tutti là a chiedersi scrupolosamente se le persone si comportano davvero per come si sentono di fare o se le loro facezie sociali rispondono solo a modelli socialmente riconosciuti come accettabili).
Vi chiederete cosa c’entra questo con Tiziano Ferro. Bene. Egli è uno degli ultimi baluardi del non essere un automa.
Il dolce caro bellissimo piccolo tesoro d’uomo qualunque orientamento sessuale egli abbia ha concesso a un botto di persone di farsi un bel pianto, una bella risata e nella maggior parte dei casi, una bella cantata liberatoria, su cose che, ci hanno insegnato, non dovrebbero essere neppure provate, figuriamoci ammesse. Oggi, per dire, è riuscito a farmi canticchiare una cosa come “il bene più segreto sfugge all’uomo che non guarda avanti mai” (ed era difficile che io canticchiassi oggi, voglio dirvelo). Insomma, chiedersi se una storia può andare avanti o meno, sentirsi più spaurito e perduto di un cucciolo di foca nella stagione della caccia (cucciolo di foca orfano, ndr.), temere che i tempi buoni vadano via troppo in fretta e che quelli cattivi restino invece cristallizzati a farci il cuore piccolo e secco come quello della pecora in formaldeide di Hirst in virtù della giustezza, della serenità, di un nirvana che nessuno si ricorda mai essere, in realtà, l’assenza di desiderio: vi sembra poca cosa renderli cantabili, condivisibili, in qualche modo anche giusti?
Tiziano Ferro è praticamente quello che ti soccorre e quando cominci a farti domande che metterebbero in crisi le più alte cariche dello Stato.
Davvero. Io sono convinta che anche la scissione del PD potrebbe essere ampiamente risolta da Tiziano. Tipo che chiudono Emiliano, Bersani, Veltroni e Renzi in una stanza e gli mettono a palla “Ti scatterò una foto” e “Potremmo Ritornare”.
- A “Siamo figli di mondi diversi e una sola memoria che cancella e disegna distratta la stessa storia”, si guardano con gli occhi lucidi – da lontano, ognuno nel proprio cantuccio, mantenendo le distanze – ma pensano: cazzo, è vero! Veltroni – che è quello a cui piace fare lo splendido capace di parafrasi che gli rendono possibile fare lo stesso discorso dal 2008 senza farsi prendere a selciate -, si sta chiedendo se la canzone è molto nota e deve citarla necessariamente nel nuovo intervento o se può farlo en passant. Renzi che è più pragmatico sta inviando un messaggio su Telegram per accertarsi a) della posizione di TZN (del resto oggi sul Corriere hanno un pezzo sulle posizioni dei VIP) b) del copyright per l’utilizzo della frase come claim della prossima futura campagna elettorale c) di nuova assemblea mozione “Tiziano” in cui è possibile esprimere il proprio parere solo ed esclusivamente citando il Ferro (Renzi ha tenuto per sé la hit “Perdono” e si sta esercitando sul verso “se quel che è fatto e fatto io però chiedo scusa – regalami un sorriso io ti porgo una rosa – su questa amicizia nuova pace si posa – perché so come sono e infatti chiedo Perdono – Scusa –“
- A “Potremmo Ritornare”, anzi al verso “Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare” stanno cercando su internet una data del Tour che non sia ancora sold-out (purtroppo ci hanno messo un po’ di tempo perché Bersani non era sicurissimo di potersi muovere quel giorno, ma poi si è convinto, ha fatto pure una battutina puntuta tipo “Oh ragassi, non è che le correnti del PD si fermano chiudendo le finestre” e Veltroni, che intanto era già andato su Google, ha scritto “Tiziano Ferro canzone su vento corrente aria fredda” gli ha risposto “E se si alzerà il vento/lo vedremo scatenare le più alte onde in mare (…) E ci darà di più di quello che c’è stato/E quello che è passato/ E sarà tuo e mio”).
Tizianuccio (l’ho nominato talmente tante volte che siamo usciti a parenti, intanto) in pratica, è l’unico che non parla di futuro come se il passato fosse interamente da rottamare (leggi: portare fuori con la spazzatura).
E se guardiamo in prospettiva gli ultimi anni, se io stessa mi volto dalla scala di Escher su cui mi sento di stare e abbasso gli occhi, Tiziano c’era. C’era e non mi ha mai fatto prendere sonore strafacciate a seguire consigli tipo “inciampa piuttosto che tacere, domanda piuttosto che aspettare”, mai. C’era e se ne usciva con una canzone nuova – non so sceglierne una sola e quindi non sceglierò – a ricordarci che paure, dubbi, domande e “nanana” sono tutte cose importanti per raggiungere l’unico obiettivo a cui mi sento di aspirare seriamente e cioè: non avere mai alcun rimpianto.
Non ne ho.
E questa è l’unica cosa che riesco a dire di me con orgoglio. Assieme al fatto che sono sicura che Tiziano Ferro capirebbe benissimo cosa intendo. E mi risponderebbe:
L’amore è una cosa semplice e adesso, adesso, adesso, te lo dimostrerò.